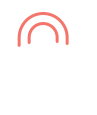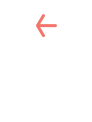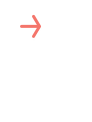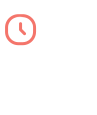di Valter Vecellio
“L’obiettivo di questi magistrati, quelli della Procura di Milano in modo particolare, è quello di costringere ciascuno di noi a rompere, definitivamente e irrevocabilmente, con quello che loro chiamano il nostro “ambiente”. Ciascuno di noi, già compromesso nella propria dignità agli occhi dell’opinione pubblica per il solo fatto di essere inquisito o, peggio, essere stato arrestato, deve adottare un atteggiamento di “collaborazione” che consiste in tradimenti e delazioni che lo rendano infido, inattendibile, inaffidabile: che diventi cioè quello che loro stessi chiamano un “infame”.
Secondo questi magistrati, ad ognuno di noi deve dunque essere precluso ogni futuro, quindi la vita, la famiglia, gli amici, i colleghi, le conoscenze locali e internazionali, gli interessi sui quali loro e i loro complici intendono mettere le mani. Già molti sostengono, infatti, che agli inquisiti come me dovrà essere interdetta ogni possibilità di lavoro non solo nell’amministrazione pubblica o para-pubblica, ma anche nelle amministrazioni delle aziende private, come si fa a volte per i falliti. Si vuole insomma creare una massa di morti civili, disperati e perseguitati, proprio come sta facendo l’altro complice infame della magistratura che è il sistema carcerario.
La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro, di tortura, psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima. Qui dentro ciascuno è abbandonato a se stesso, nell’ignoranza coltivata e imposta dei propri diritti, custodito nell’inattività e nell’ignavia; la gente impigrisce, istupidisce, si degrada e si dispera diventando inevitabilmente un ulteriore moltiplicatore di malavita.
Come dicevo, siamo cani in un canile dal quale ogni procuratore può prelevarci per fare la sua propria esercitazione e dimostrazione che è più bravo o più severo di quello che aveva fatto un’analoga esercitazione alcuni giorni prima, o alcune ore prima. Anche tra loro c’è la stessa competizione o sopraffazione che vige nel mercato, con la differenza che, in questo caso, il gioco è fatto sulla pelle della gente. Non è dunque possibile accettare il loro giudizio, qualunque esso sia. Stanno distruggendo le basi di fondo e la stessa cultura del diritto, stanno percorrendo irrevocabilmente la strada che porta al loro Stato autoritario, al loro regime della totale asocialità.
Io non ci voglio essere. Hanno distrutto la dignità dell’intera categoria degli avvocati penalisti, ormai incapaci di dibattere e di reagire alle continue violazioni del nostro fondamentale diritto di essere inquisiti, e giudicati poi, in accordo con le leggi della Repubblica. Non sono soltanto gli avvocati, i sacerdoti laici della società, a perdere questa guerra; ma è l’intera nazione che ne soffrirà le conseguenze per molto tempo a venire.
Già oggi i processi, e non solo a Milano, sono farse tragiche, allucinanti, con pene smisurate, comminate da giudici che a malapena conoscono il caso, sonnecchiando o addirittura dormendo durante le udienze per poi decidere in cinque minuti di camera di consiglio. Non parliamo poi dei tribunali della libertà, asserviti anche loro ai pubblici ministeri, né dei tribunali di sorveglianza che infieriscono sui detenuti condannati con il cinismo dei peggiori burocrati e ne calpestano continuamente i diritti.
L’accelerazione dei processi, invocata e favorita dal ministro Conso, non è altro che la sostanziale istituzionalizzazione dei tribunali speciali del regime di polizia prossimo venturo. Quei pochi di noi caduti nelle mani di questa “giustizia” rischiano di essere i capri espiatori della tragedia nazionale generata da questa rivoluzione.
Io sono convinto di dover rifiutare questo ruolo. È una decisione che prendo in tutta lucidità e coscienza, con la certezza di fare una cosa giusta. Le responsabilità per colpe che posso avere commesso sono esclusivamente mie e, mie, sono le conseguenze.
Esiste certamente il pericolo che molti altri possano attribuirmi colpe non mie quando non potrò più difendermi.
Affidatevi alla mia coscienza, in questo momento di verità totale, per difendere e conservare sul mio nome la dignità che gli spetta”.
Questa lettera ha una data: 10 luglio 1993. Il suo autore si chiamava Gabriele Cagliari, 67 anni, un “potente”, manager di lungo corso; presidente dell’ENI, per ordine della procura di Milano in carcere per 134 giorni. Lo accusano di tangenti. In carcere scrive ai familiari e agli amici. Ventotto lettere, che il figlio Stefano pubblica: Storia di mio padre (Longanesi, a cura di Costanza Rizzacasa d’Orsogna).
Lo arrestano l’8 marzo 1993. Cagliari non nega il “regime” fondato sul finanziamento illecito dei partiti. Chiede però di essere trattato secondo giustizia e diritto: “Abbiamo fatto troppe cose senza accorgerci che la rete non c’era più e non possiamo illuderci di non dover pagare almeno un poco”, scrive in una lettera del 4 maggio 1993. “Certo, possiamo pretendere di non dover difenderci davanti a tribunali speciali, come sembra essere questa magistratura di Milano, in particolare, che mi tiene qui in violazione di ben chiare leggi dello stato, al solo scopo di farmi rivelare chissà quali segreti. E poi perché qualche contenuto simbolico e politico la mia immagine, pure distrutta come l’hanno voluta, ancora ce l’ha e questo serve al supporto che la piazza continua a dare a questi giudici. Certamente meritevoli e coraggiosi ma anche ambiziosi di potere e di gloria”.
Fa impressione il passaggio dove denuncia: “Ci trattano veramente come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile”.
La privazione della libertà nei confronti di Cagliari, per un tempo spropositatamente lungo, è semplicemente illegittima. Su cosa si fonda la carcerazione preventiva? Pericolo di fuga? Inquinamento delle prove? Reiterazione del reato? Niente. È evidente che lo si tiene chiuso in cella perché parli, denunci altri. Come ammette uno dei magistrati del pool milanese di “Mani pulite”: “Chi racconta come sono andate le cose, restituisce ciò di cui si è appropriato indebitamente e si allontana per qualche anno dalla vita pubblica non va in prigione”. Un invito alla delazione.
Cagliari non ci sta. Il 20 luglio 1993, dopo l’ennesimo tentativo di scarcerazione fallito, lo trovano morto nelle docce del carcere milanese di San Vittore, un sacchetto di plastica in testa. Non è questa la sede per ripercorrere, discutere e ragionare la stagione di “Mani Pulite” e quello che ha comportato e tuttora comporta. Ma impressionante è il passaggio relativo al carcere, le condizioni dei detenuti; l’uso che si fa della detenzione.
Rileggiamo: “La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro, di tortura, psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima. Qui dentro ciascuno è abbandonato a se stesso, nell’ignoranza coltivata e imposta dei propri diritti, custodito nell’inattività e nell’ignavia; la gente impigrisce, istupidisce, si degrada e si dispera diventando inevitabilmente un ulteriore moltiplicatore di malavita”.
Se questa era la condizione di un potente come Cagliari, figuriamoci gli altri…
La prima edizione è del gennaio 2010: In attesa di giustizia (Guerini editore), autori Giuliano Pisapia, avvocato penalista, parlamentare per svariate legislature, ora deputato al Parlamento Europeo; e Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia, ora eletto parlamentare e ministro della Giustizia. È un dialogo, quasi sempre l’uno completa il pensiero dell’altro.
Si chiedono se il carcere davvero assolve lo scopo che la Costituzione affida alla pena.
Nordio: “…Le due manifestazioni più gravi della disperazione carceraria, le rivolte di molti e il suicidio di alcuni, non sono fenomeni esclusivamente italiani. Sono diffusi in tutto il mondo civile, e traggono origine dalla miscela esplosiva, e solo apparentemente contraddittoria, della promiscuità e della solitudine”.
Pisapia: “Tempo fa tre giudici della Californi hanno messo sotto accusa lo Stato perché ‘alimenta nei suoi penitenziari condizioni criminogene’ e hanno ordinato la liberazione di 43mila detenuti”.
Nordio: “Tutte le galere soffrono le stesse carenze di spazi, di personale e di igiene; e benché siano complessivamente assai più umane di quelle di un tempo, sono meno tollerate dall’uomo moderno, meno assuefatto dei suoi antenati alla sofferenza, e più consapevole dei suoi diritti naturali…”.
Pisapia: “Accantoniamo per un attimo – e mi è difficile farlo – il numero dei suicidi che è in continuo aumento, il bollettino dei decessi che segna un morto ogni due giorni, l’acqua che non scorre, la turca davanti ai fornelli, il nulla della giornata che si consuma per molti in oltre 16 ore al giorno buttati sulla branda, la crisi dei tossicodipendenti in astinenza, le risse, la privazione di affetti e di futuro. Mettiamo da parte tutto questo e chiediamoci: come sarà, una volta tornato libero, l’uomo che ha vissuto in quelle condizioni i suoi anni da detenuto?”.
Nordio: “Siamo d’accordo tutti, giudici, avvocati che il sistema carcerario è inconcepibile con la rieducazione, perché troppo brutale. Le sue strutture edilizie e le condizioni inumane sono al limite della tolleranza, non per colpa dei giudici, né tantomeno dei secondini, ma sono una vergogna della nostra pretesa civiltà giuridica”.
A questo punto è un falso parlare di “emergenza ignorata”. È, piuttosto, un’ordinaria emergenza che si vuole ignorare. La questione, comunque, è scomparsa dai radar della politica, sia di chi governa che di chi si colloca all’opposizione. Ma sanno. Sanno tutti, tutto, da tempo.
Si prenda un articolo di Fiorenza Sarzanini, vice-direttrice del Corriere della Sera. “È un viaggio nell’orrore l’ultimo bollettino reso noto dal Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria”, scrive. “Perché meglio di ogni petizione o appello racconta che cosa succede nelle carceri e soprattutto quanto è urgente intervenire. Meglio di ogni dibattito parlamentare evidenzia che cosa avviene ogni giorno nelle celle, quanto basso sia ormai il livello di vivibilità…”.
Segue un lungo elenco di cifre, relative agli atti di autolesionismo, i suicidi, i tentati suicidi, i ferimenti, le colluttazioni, le manifestazioni di protesta contro il sovraffollamento per chiedere provvedimenti come amnistia e indulto, in ogni caso provvedimenti che servano davvero a migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri.
Scrive Sarzanini: “Secondo il sindacato è necessario e urgente, oltre alla firma di accordi tra Stati per far scontare nel proprio Paese la pena agli stranieri, una riforma strutturale della pena detentiva che ponga al centro l’obbligatorietà del lavoro dei detenuti perché questo alleggerisce certamente la tensione nelle celle e fornisce una concreta possibilità di recupero sociale. Servono soldi, ma serve soprattutto un impegno serio del governo perché è inaccettabile che nelle carceri si viva come bestie in un macello”.
Questo articolo sembra scritto oggi per l’oggi. Invece no: la data è quella del 29 marzo 2014, ben undici anni fa, pubblicato su Io donna, settimanale del Corriere della Sera, dove Fiorenza era titolare della rubrica “Fuori verbale”. Da allora, la situazione è peggiorata. Basti dire che, quando l’articolo è stato scritto i suicidi ufficiali dei detenuti erano 42.
Se c’è una cosa detestabile, lessicalmente, è il gerundio: quando si dice: “Sto arrivando”, buona regola sarebbe correggere: “No, o arrivi o non arrivi”. Da sempre, per quel che riguarda il carcere, dicono: “Stiamo lavorando”. Come testimonia l’articolo del 2014 di Fiorenza Sarzanini quel gerundio si traduce in un nulla di fatto.
L’occasione è stata la festa per i 207 anni dalla costituzione della Polizia Penitenziaria. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un “saluto” non formale. Rivolto agli agenti, il Presidente riconosce che sono costretti a operare in “…condizioni particolari, piene, appunto, di difficoltà. Questo richiede un sovrappiù di professionalità, e io vi ringrazio per il lavoro che spiegate e per l’impegno che viene manifestato dall’amministrazione di svilupparla il più possibile, costantemente. Conosco, naturalmente, altri ostacoli che gravano sul vostro compito e le vostre attività. Ostacoli che richiamano il compito di altre istituzioni. Dal sovraffollamento carcerario, che rende difficile il vostro lavoro, molto più di quanto non dovrebbe essere, alle carenze di organico che pesano certamente, sovraffaticando il compito di ciascuno di voi, a quello che, in questo momento, è forse un elemento prioritario: l’esigenza di assistenza sanitaria dentro gli istituti penitenziari. È un’esigenza diffusa, ampia, indispensabile; la mancanza della quale fa sì che su di voi ricadano esigenze, sollecitazioni, richieste che non rientrano nei vostri compiti e nelle vostre funzioni. Per questo è indispensabile che si affronti sollecitamente questo aspetto di un’efficace assistenza sanitaria dentro gli istituti penitenziari. Tutti questi aspetti richiedono interventi urgenti: completamento di organici, risposte al sovraffollamento carcerario e – ripeto – sopra ogni cosa, assistenza sanitaria. Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontarlo immediatamente, con urgenza…”.
Gli stessi concetti vengono ribaditi in occasione del tradizionale messaggio di fine anno: un lungo passaggio del discorso riguarda la questione delle carceri e alla condizione in cui è costretta a vivere l’intera comunità penitenziaria.
Tutti gli “inquilini” del “Palazzo”, sia chi “governa”, sia chi è all’opposizione non muovono rilievo alcuno al discorso del Presidente. È da credere che siano d’accordo; anche per quel che riguarda il monito/appello relativo alle carceri e ai detenuti. Ma nulla fanno e hanno fatto per sanare la situazione. Anzi, nei fatti lavorano perché ulteriormente incancrenisca. Stessa inerzia, stessa indifferenza nei confronti del Pontefice, giunto ad aprire una simbolica Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia e chiede esplicitamente provvedimenti di clemenza. Una indifferenza colpevole; un’inerzia dolosamente colpevole.
conversazione con Giovanni Maria Flick
Giurista e uomo politico italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza entra in magistratura e lavora al tribunale di Roma come giudice e come pubblico ministero. Nel 1976 lascia la magistratura per intraprendere la carriera di avvocato penalista, che interrompe nel 1996 quando è nominato Ministro della Giustizia del primo governo Prodi. Dà seguito ad un voto parlamentare, e chiude per decreto le carceri di Pianosa e dell›Asinara. Presenta lo stesso anno in Parlamento una serie di leggi organiche di riforma del sistema giudiziario che verranno approvate quasi integralmente, in un iter che terminerà alla fine del 1999. Fra queste, l›istituzione di un singolo giudice per i reati di entità minore che prima richiedevano l›impiego di tre magistrati, varato con l›intento di venire incontro al problema della lentezza dei procedimenti giudiziari italiani. Nel 2000 è nominato giudice della Corte costituzionale, di cui nel 2005 è vicepresidente. È poi presidente della Consulta dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009. Professore emerito di Diritto penale all’Università Luiss di Roma, dove ha insegnato dal 1980 fino alla nomina a giudice costituzionale. Tra i suoi libri: Elogio della dignità (2015), Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio (2016), Elogio della Costituzione (2017), L’algoritmo d’oro e la torre di Babele. Il mito dell’informatica (2022).
——————————————–
Domanda: “Professore, solo nel 2024 almeno una novantina di detenuti si sono tolti la vita; si tratta di quelli “ufficiali”; nei primi mesi del 2025 quasi venti… A questa macabra contabilità vanno compresi anche una decina di agenti della polizia penitenziaria…”.
Giovanni Maria Flick: “Ogni suicidio è una tragedia e deve farci riflettere; ma in particolare sono i suicidi degli agenti a costituire cosa più inquietante; anche gli altri, non vorrei essere equivocato, mi preoccupano; ma che anche agli agenti della polizia penitenziaria condividano una disperazione analoga a quella dei detenuti, uno stato di grave stress dei detenuti, dovrebbe far pensare, è un segnale d’allarme che purtroppo non mi sembra sia colto come si dovrebbe …”.
Domanda: “Ogni tanto se ne parla, si evoca la questione; ma è di tutta evidenza che non fa parte dell’agenda politica, né quella del Governo né quella delle opposizioni…”.
Flick: “In effetti, l’unica reazione è quella di dire: ‘Sorvegliamoli di più, reprimiamoli di più’; ma non è così che si risolve il problema”.
Domanda: “Che fare? Cosa si può e cosa si deve fare?”.
Flick: “Di carcere mi sono occupato, continuo a farlo. Ho maturato una convinzione che forse può stupire qualcuno: l’esperienza mi ha convinto che il carcere sia incostituzionale”.
Domanda: “Detto da un presidente emerito della Corte costituzionale, già ministro della Giustizia…”.
Flick: “Proprio perché ho studiato legge tutta la vita, ho cercato di tradurne i precetti e trasformarli in scelte e opzioni che diano concrete risposte ai problemi, e per aver ricoperto gli incarichi che avete ricordato, tutto questo ora mi fa dire che il carcere in Italia contraddice la Costituzione…La situazione di illegalità del nostro sistema carcerario e della condizione dei detenuti (come dei migranti “irregolari”) è stata denunziata ampiamente ed esplicitamente dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU per la tutela dei diritti umani. Prima ancora, a denunziarla si sono levate e continuano a levarsi moltissime voci, fra cui quelle autorevoli (da ultimo) di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco, di ben due presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano e di Sergio Mattarella…”.
Domanda: “Inascoltati dal potere politico…”.
Flick: “Non solo. È paradossale l’alternativa cui ci troviamo di fronte, dopo le condanne della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Da un lato il potere politico risponde all’emergenza carcere pressoché soltanto con il programma di costruire nuove carceri. Dall’altro lato il potere giudiziario cerca di rispondere con la richiesta di non eseguire la condanna che ha appena pronunziato, in assenza di posti e spazi regolamentari per i detenuti. È una ennesima riprova della necessità di ricorrere alla supplenza giudiziaria, per cercare di risolvere problemi che si trascurano da troppo tempo e che non vengono affrontati in modo radicale, come si dovrebbe”.
Domanda: “Come se ne esce?”.
Flick: “Per sfuggire a una simile alternativa è indifferibile esplorare seriamente e concretamente una terza via: il passaggio dal carcere alla libertà; il coinvolgimento della società civile per rendere concreta una simile possibilità; il rafforzamento delle potenzialità dell’articolo 27 della Costituzione con il richiamo alla tutela dei cosiddetti ‘residui di libertà’ compatibili con la privazione delle libertà personali e le esigenze di sicurezza, mediante il richiamo agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Lo studio dei molteplici problemi ed effetti negativi della pena attraverso quella privazione si risolse però in una panoramica solo teorica per ragioni politiche. Si sviluppò allora e comunque la ricerca di soluzioni concrete e operative per migliorare la vita nella quotidianità del carcere senza dover ricorrere a modifiche legislative che erano osteggiate dalla gran parte dell’opinione politica e sociale. Si sono affermati esigui interventi di riforma con le pene sostitutive. Soprattutto si è avviata una riflessione – tradotta con alcune iniziative timide di riforma – sulla “giustizia riparativa”, per supplire alla carenza del sistema penale e penitenziario tradizionale attraverso la ricostruzione del rapporto fra condannato e vittima; con tutti i dubbi, i problemi e le difficoltà, che si propongono rispetto alla realtà del carcere e alle perplessità, se non all’ostilità, dell’opinione pubblica e politica. Realisticamente occorre evitare che il richiamo alla “giustizia riparativa” e ai suoi sperati vantaggi diventi una sorta di “bacchetta magica” per continuare a ignorare e nascondere le drammatiche disfunzioni del sistema carcerario del nostro paese. Di fronte a questa situazione l’atteggiamento della politica come della società civile continua ad essere in prevalenza – al di là delle parole di circostanza – l’indifferenza, quando non la paura e il rifiuto del nuovo”.
Domanda: “Piero Calamandrei, uno dei costituenti, giurista che non ha bisogno di presentazione, propose una commissione parlamentare d’inchiesta sul carcere e sollevò fin da allora, si sta parlando degli anni del dopoguerra, dei suicidi…”.
Flick: “Calamandrei vedeva, come era giusto, nel Parlamento, un momento di vertice della sovranità e quindi la garanzia di un discorso serio per una questione già allora scottante…”.
Domanda: “In un’Italia che si dibatteva in ben più gravosi problemi Calamandrei ha l’illuminazione di capire che le carceri sono uno snodo cruciale per la civiltà giuridica e non solo di un paese reduce da una dittatura e dalla guerra…”.
Flick: “Il fatto è che il carcere ha sempre conservato alcune caratteristiche, alcune stimmate che vanno al di là dei regimi: la violenza, la burocrazia, la chiusura; questi erano elementi presenti anche prima dell’affermazione del fascismo, nello Stato preunitario; si sono poi accentuate nel periodo della dittatura fascista e sono continuate anche nel periodo repubblicano”.
Domanda: “Lei pensa che sia opportuno, che possa essere utile una parlamentare che si occupi specificatamente della questione?”.
Flick: “Dati i numeri del fenomeno, le sue dimensioni, direi che sia proprio indispensabile. I suicidi in carcere sono una realtà veramente preoccupante: il segno di una carenza dello Stato”.
Domanda: “Torniamo al carcere incostituzionale…Si riferisce all’annosa questione del sovraffollamento e alle condizioni di vita dei detenuti?”.
Flick: “Anche a quello; è incivile che i detenuti, che sono persone anche loro titolari di diritti come tutti, siano costretti a vivere in spazi ridotti, e si discuta se i tre metri quadrati per tre debbano comprendere anche lo spazio occupato dal mobilio o no…; c’è anche questo, ma sono arrivato all’idea che il carcere sia incostituzionale proprio come idea di fondo”.
Domanda: “Cioè lei sostiene che al di là delle condizioni di vita è proprio l’istituzione carcere a essere in contrasto con la Costituzione?”.
Flick: “Esattamente. Vedete, l’articolo 27 della Costituzione è di una chiarezza cristallina: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. Qualcuno può sostenere che nelle carceri italiane al di là del trattamento al detenuto si garantisca la rieducazione?”.
Domanda: “Non garantendo rieducazione siamo fuori dalla Costituzione?”.
Flick: “Il fatto è che il carcere, proprio perché tale, non può garantire la rieducazione e il reinserimento di cui parla la Costituzione. Più in generale: qual è il criterio, la “filosofia” che finora ci anima? Ci limitiamo a privare della libertà e isolare le persone che hanno violato le leggi o si crede lo abbiano fatto. Ma ci si ferma a questo: la limitazione della libertà e questa privazione è l’unico modello di pena. Credo che prima o poi ci si dovrà convincere che occorre individuare altri tipi di sanzione, altri tipi di pene che non siano la privazione della libertà”.
Domanda: “Con le carceri accade un po’ quello che accadeva con i manicomi: si rinchiudeva il diverso, considerato automaticamente perverso e minaccioso per la società, e ci si sentiva per questo più sicuri…”.
Flick: “In effetti è la stessa matrice, la stessa logica. Isolare chi dà fastidio, o per una sua patologia o per il suo comportamento, e ci si illude così di aver risolto il problema. Il ricorso alla privazione della libertà personale diventa in realtà lo strumento per isolare quel singolo dalla società nella quale non si trova o per la quale è di fastidio. Gira e rigira il problema è un po’ questo”.
Domanda: “Abolire il carcere sarebbe molto bello. Ma siamo nel terreno dell’utopia, non le pare?”.
Flick: “Allora diciamo meglio. Alla luce di esperienze che si ripetono purtroppo frequentemente è prioritario fare in modo che il carcere sia veramente e soltanto una misura di extrema ratio; panpenalizzazione e pancarcerizzazione non sono certo la via per riportare la persona al centro della società, come chiede la Costituzione. Quella del carcere è una situazione di illegalità conclamata del nostro paese, dove il sovraffollamento ha carattere non contingente, bensì strutturale e legato alla identificazione quasi assoluta fra pena e carcere. Quella identificazione è esclusa dall’articolo 27 della Costituzione, che parla esplicitamente di “pene”.
Domanda: “Siamo sempre nel terreno delle dichiarazioni di principio. Auspicabile, desiderabile; ma poi ci si deve calare nella realtà…”.
Flick: “Prima abbiamo citato l’articolo 27 della Costituzione. Ora prendiamo l’articolo 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Accostiamolo all’articolo 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Poi gli altri diritti sociali, quelli al lavoro, alla cultura, alla casa… La Costituzione garantisce tutti questi diritti, direi che quasi pedantemente li elenca…A questo punto, alla luce di quanto ho detto il problema del carcere diventa fondamentale; e si apre tutto il discorso della formazione della personalità di ciascuno di noi attraverso la vita con gli altri, attraverso la relazione con gli altri: tutte le forme di relazione della persona, quella affettiva, familiare, culturale con gli altri… Tutte le relazioni soffrono una grande limitazione in questo tipo di discorso. È il primo problema che a me lascia molto perplesso di fronte all’opzione per il carcere come pena tipo, per la su stessa definizione”.
Domanda: “Come conciliare esigenza di sicurezza, le relazioni di cui tutti abbiamo diritto, il concetto di rieducazione?
Flick: “I costituenti sono stati saggi e realisti. Non hanno scritto che la persona va rieducata, ma che le pene devono tendere alla rieducazione. Perché, se le pene avessero come principio vincolante rieducare, probabilmente la maggior parte delle pene sarebbe incostituzionale. Lo dimostra proprio la percentuale, il rapporto tra recidiva tra chi sconta la pena in carcere, e la recidiva, notevolmente inferiore, di chi invece la sconta fuori dal carcere, con strumenti esterni. È chiaro che tutto questo urta poi contro l’aggressività. Quando c’è violenza, aggressività e violenza, questo discorso regge fino a un certo punto, nel concreto. Ma è un discorso che non devi mai dimenticare”.
Domanda: “Torniamo alla questione da cui siamo partiti: i suicidi in carcere…”.
Flick: “E’ impressionante, nel numero dei suicidi, la giovane età do chi si toglie la vita; sono soprattutto i giovani adesso che si suicidano. Come ha osservato anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il suicidio è una specie di fuga, è l’unico tipo di fuga dal carcere”.
Domanda: “Ancor di più se si tiene conto dei tantissimi e non censiti, tentati suicidi sventati grazie al pronto e lodevole intervento della polizia penitenziaria e del personale carcerario…”.
Flick: “Se si tiene conto anche dei propositi suicidari che non vanno in porto la questione assume dimensioni particolarmente inquietanti…”.
Domanda: “Molti detenuti inoltre si tolgono la vita quando manca poco alla scarcerazione, qualche mese prima di essere liberati”.
Flick: “Poco tempo per noi…Per un detenuto anche solo qualche mese di detenzione può risultare insopportabile. Non sappiamo poi quanti sono atterriti dall’idea di quello che li aspetta, o non li aspetta, fuori…”.
Domanda: “Per una qualsivoglia ragione lo Stato priva un cittadino della sua libertà. Quando lo fa non si rende automaticamente garante della sua sanità, fisica e psichica? Se un cittadino privato della sua libertà si uccide, lo Stato non diventa automaticamente responsabile della sua morte o della sua menomazione?”.
Flick: “Mi chiede se un suicidio in carcere sia anche qualcosa che non sia “solo” un suicidio? È difficile tipizzarlo. Certo: nel caso di un detenuto si deve sempre andare alla ricerca di possibili responsabilità, scoprire se ci possono essere state delle concause, delle mancanze. Voi ponete la questione se lo Stato nel momento in cui priva la libertà a una persona ne diventa automaticamente responsabile… Che sia garante delle sue condizioni di salute è fuori discussione. Lo Stato ha dei precisi doveri nei confronti di quella persona reclusa…Soprattutto se è in attesa di giudizio, quindi tecnicamente innocente”.
Domanda: “Non accade, nella pratica”.
Flick: “Il problema è anche nella difficoltà di individuare le responsabilità: possono essere di un agente della polizia penitenziaria, del direttore del carcere…”.
Domanda: “Anche di livelli superiori…”.
Flick: “Anche di livelli superiori. E certamente lo Stato andrebbe chiamato a risarcire, anche se la perdita di una vita non ha prezzo, evidentemente…”.
Domanda: “Un discorso che si può allargare anche ad altre istituzioni. Pensiamo al regista Mario Monicelli: si getta dalla finestra di un ospedale…”.
Flick: “Capisco quello che volete dire: un ospedale è un luogo tenuto alla cura…ma sono purtroppo casi che possono capitare. In astratto l’istituzione dovrebbe essere in qualche modo responsabile; quanto a poter tradurre in concreto questa responsabilità… Per quel che riguarda il carcere, però questa responsabilità è più facile accertarla”.
Domanda: “E’ azzardato sostenere che per ogni suicidio si dovrebbe istruire un processo?”
Flick: “Un’inchiesta senza dubbio. Magari poi si stabilisce che il fatto non esiste in quanto reato e non necessariamente si arriva a un processo. Il suicida potrebbe aver approfittato di un momento di distrazione…l’indagine dovrebbe in un modo o nell’altro verificare se c’è stata una condotta effettiva e attiva per impedire che accadesse il fatto”.
Domanda: “Stesso discorso vale per la salute in carcere, quando non viene garantita, come spesso accade…”.
Flick: “Non c’è dubbio che la persona che è arrestata è sotto custodia dello Stato anche per quanto riguarda la conservazione della sua salute. Dovrebbe assicurare tutti gli strumenti che possono servire per garantire la sua salute. È un problema, ed è tale a causa del sovraffollamento delle carceri”.
Domanda: “Da quanto ci dice si ricava che forse la cosa migliore è lasciare il più possibile la Costituzione così com’è; essere molto cauti e prudenti per quel che riguarda modifiche, cercare piuttosto di attuarla…”.
Flick: “Sì, bisogna essere molto prudenti quando si parla di Costituzione. I padri costituenti avevano lo sguardo lungo”.
Domanda: “Lei per ipotesi è nuovamente il ministro della Giustizia…”.
Flick: “Mi dimetto subito”.
Domanda: “Dimissioni respinte. Cosa farebbe se disponesse dei poteri per fare quello che crede necessario?”.
Flick: “La questione carceraria è incancrenita al punto che non sarebbe serio far credere che ci siano formule e pratiche rapide e veloci. Non è dell’uomo fare miracoli. Però tra le primissime cose che farei è cercare di porre rimedio al sovraffollamento. Ci sono troppe persone in carcere. Bisogna fare un maggiore ricorso alla detenzione domiciliare o in strutture alternative. Il carcere ha sempre funzionato male perché ci sono troppe persone in cella. Bisogna avere l’umiltà di capire e forse ricominciare da capo, giorno per giorno, passo per passo nelle piccole cose”.
Domanda: “E per quel che riguarda gli agenti della polizia penitenziaria, gli operatori?”
Flick: “Sono costretti a lavorare in condizioni stressanti, faticosissime. Anche questo è un problema che andrebbe affrontato con urgenza e coscienza. Per inciso: responsabilità gravose e in cambio un lavoro tra i meno remunerativi”.
Domanda: “Una commissione parlamentare oggi potrebbe essere utile?”
Flick: “Utile, sì. Non risolve, perché questi sono problemi che richiedono sforzi coordinati, metodici e di respiro. Ma aiuterebbe ad acquisire conoscenza e consapevolezza. Tra i legislatori per primi. A determinate condizioni, però”.
Domanda: “Quali condizioni?”
Flick: “Il primo requisito: abbandonare ogni spirito e tentazione partigiana. Nelle più recenti esperienze di inchiesta parlamentare di inchiesta ci ho sempre visto soprattutto l’anima politica, la divisione tra l’una e l’altra parte; alla fine i risultati sono peggiori del male che vorrebbero curare. Va scongiurato il vizio della politicizzazione estrema, della radicalizzazione e della divisione tra maggioranza e opposizione”.
conversazione con Massimo Barra
Laureato in medicina con lode nel 1972, ha due grandi priorità per le quali ha speso tutto se stesso: La Croce Rossa ed il recupero dei tossicomani. Entrato fin dall’età di otto anni in Croce Rossa, ne assume molteplici funzioni fino ai massimi vertici in Italia (Presidente Nazionale) e a livello Internazionale (Presidente della Commissione Permanente di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa). Attualmente è Presidente Nazionale emerito della CRI. Ha partecipato alle azioni di soccorso in occasione delle principali emergenze in pace e guerra, in Italia ed all’estero, tra cui l’alluvione di Firenze, i terremoti del Belice, del Friuli, dell’Irpinia e di Umbria e Marche, ed i conflitti in Afganistan (Kabul), Iraq (Bagdad e Nassiryia), Libano (Beirut) e Palestina (Ramallah). Ha compiuto missioni in oltre 120 paesi di tutti i continenti. Dal 1974 cura i tossicomani, prima nel Centro Malattie Sociali del Comune di Roma, poi dal 1976 nel centro Villa Maraini da lui fondato. È autore di centinaia di articoli, discorsi e pubblicazioni a stampa, aventi per tema la Croce Rossa e la politica umanitaria sulle droghe da lui promossa. È stato il primo al mondo a promuovere l’uso del Naloxone da parte del personale non medico, in caso di overdose. Ciò che ha permesso di salvare oltre 3.000 pazienti nelle strade di Roma. È più volte intervenuto in sedi istituzionali all’ONU (New York, Ginevra e Vienna), al Consiglio d’Europa, al Parlamento europeo, italiano e brasiliano. È stato membro del CDA del Global Fund. Nell’ambito della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ricopre l’incarico di Presidente della Partnership on Substance Abuse e di Presidente Onorario di ERNA (il network europeo di Croce Rossa per HIV, epatiti e droga). Massimo Barra è inoltre l’ideatore del Manifesto “Per una politica umanitaria sulla droga – Rome Consensus”, presentato alle Nazioni Unite a Vienna nel 2020.
——————————————–
Domanda: “Carcere: un mondo, un universo con una quantità di problematiche. Una di queste, la punta dell’iceberg, l’alto numero di detenuti che decidono di togliersi la vita tra i detenuti. Numericamente possono apparire cifre irrisorie, una novantina nel 2024 i suicidi “ufficiali”. Percentualmente, se si fa il rapporto con la popolazione carceraria, diventa una cifra inquietante. A questo dato ne occorre aggiungere un altro: almeno sette agenti della polizia penitenziaria si sono uccisi. Non sappiamo quali siano le motivazioni all’origine di questo loro gesto estremo. Magari si sarebbero tolti la vita anche se avessero svolto un altro lavoro; è tuttavia lecito chiedersi se il luogo dove operavano e vivevano in buona parte della loro giornata non abbia in qualche modo contribuito; se le cause non vadano cercate anche nelle condizioni in cui lavoravano…”.
Barra: “Inquietudine è il termine giusto; aggiungo che motivo di inquietudine è l’indifferenza da parte della politica, dei mezzi di informazione, di tutti noi opinione pubblica, verso questa problematica; inquietudine che si aggiunge a ulteriore inquietudine: stiamo parlando di persone che per la maggior parte dei casi probabilmente non si doveva trovare dove invece era ristretta: malati, poco importa se fisici o psichici; persone fragili, deboli, che non devono stare rinchiuse in una cella di pochi metri quadrati, in una logica da discarica sociale…”.
Domanda: “Quello che colpisce è anche l’età dei detenuti suicidi: spesso si tratta di giovani, alcuni dei quali arrestati qualche settimana o mese prima, e che precipitano in uno stato di disperazione tale che rende loro insopportabile vivere; anche se la condanna da scontare è lieve, perfino se manca qualche mese o anno per tornare liberi”.
Barra: “Per la mia esperienza proprio i giovani, e quelli con condanne lievi spesso si rivelano i più fragili e bisognosi di assistenza. È evidente che in uno spazio ristretto come quello di una cella non è possibile assicurare come si dovrebbe quell’assistenza e quella ‘cura’ di cui hanno bisogno e diritto”.
Domanda: “Era da poco finita la guerra, siamo nel 1948; Piero Calamandrei, propone la costituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla specifica questione dei suicidi in carcere: già allora…”.
Barra: “Gli si fosse stato dato ascolto… Aveva colto l’essenza della questione. Se esaminiamo storicamente il problema, ci si rende conto che nel corso dei secoli, dal medioevo ai giorni nostri, il concetto del carcere e della detenzione è rimasto immutato: si chiami Castel Sant’Angelo o Regina Coeli, o carceri relativamente moderne come Rebibbia a Roma, la concezione non presenta alcuna evoluzione. Su tutti i campi l’umanità ha fatto progressi straordinari; per quel che riguarda il carcere, nella sostanza, la situazione è rimasta quella di cinquecento anni fa…Possibile che in tutto questo tempo l’umanità non abbia trovato un sistema più avanzato, migliore?”.
Domanda: “Come se lo spiega?”.
Barra: “Ci ho riflettuto molto e spesso. Il problema è il potere. Il carcere è uno degli strumenti con i quali si esercita il potere: quello di privare una persona della sua libertà; nel momento in cui sei chiuso in una cella non solo sei ristretto in uno spazio limitato. Dipendi da qualsiasi cosa e non hai più una volontà tua. Il tempo stesso si dilata e perde la sua originaria dimensione. Nelle piccole cose: hai bisogno di una coperta? Devi fare la domanda, e non te la danno subito. Aspetti un tempo indefinito e senza motivo. Ho fatto l’esempio della coperta, ma potrei dire una cosa semplice come scrivere una lettera o riceverla. Prima che sia inoltrata o ti arrivi tra le mani, passano giorni e giorni, senza motivo. O meglio: il motivo c’è: renderti consapevole che sei un numero, senza identità. Sono meccanismi che creano atmosfere mefitiche, per cui definisco il carcere patologico: non è normale e patogeno; crea patologia. Una patologia che non è legata solo al detenuto: stanno male tutti; nel carcere nessuno ha il potere, la gente sopravvive in funzione del potere”.
Domanda: “Il suicidio, dunque, diventa il modo per evadere, in un modo atroce si recupera quella libertà di cui il potere priva…”.
Barra: “Nell’essenza è così. La patologia del carcere si lega alla totale mancanza di potere e alla totale insoddisfazione. I detenuti sono trattati come dei sudditi, come degli schiavi, dei servi della gleba. Già ‘solo’ trattarli meglio avrebbe un effetto terapeutico. Faccio esempi spiccioli: per una qualsivoglia cosa occorre fare la cosiddetta “domandina”, che va compilata, poi inoltrata, vagliata, anche per le cose più semplici c’è questa procedura che potrebbe essere comodamente snellita e superata. Perché non lo si fa?”.
Domanda: “Pigrizia burocratica?”.
Barra: “Penso sia voluta, alla base c’è un calcolo, un’astuzia. Si vogliono recidere i punti di contatto tra chi è ‘dentro’ e chi è ‘fuori’, e questo è patogeno: crea patologia, è una forma di violenza. La mia esperienza mi ha insegnato che violence brings violence, la violenza porta altra violenza. Sempre, e può essere violenza camuffata, ‘candidi’: la peggiore di tutte le violenze…può diventare una bomba esplosiva, basta un nulla perché esploda con effetti devastanti”.
Domanda: “Come se ne esce?”.
Barra: “Per quello che riguarda il mio campo, le tossicodipendenze e chi fa uso di sostanze tossiche, parlo di humanitarian drug policy; perché non una humanitarian prison policy, trattare le persone con rispetto, umanità…La punizione consiste nel privarlo della libertà di movimento; trattarli in modo indegno va al di là della pena, mentre tante sono le cose che si possono fare coinvolgendo i detenuti se li si vuole davvero recuperare come, per inciso, prescrive la Costituzione. Certo, tutto questo contraddice la logica del Potere di cui ho parlato prima…”.
Domanda: “Secondo lei c’è dunque una precisa volontà perché la situazione sia quella che è…”.
Barra: “Non mi azzardo a dire che nelle stanze dei ministeri si studino piani e progetti in questo senso. Dico che quello che accade si inserisce perfettamente nella logica del Potere. Non bisogna essere laureati per capire che l’attuale organizzazione del carcere non può che produrre i frutti che dà. Ma davvero qualcuno può pensare che per chi ha bisogno di assistenza psicologica sia sufficiente vedere per un paio di minuti uno psicologo ad ogni morte di papa? cosa volete che possa fare un operatore, in quelle condizioni? Stesso discorso quando un detenuto si sente male. Fatta tutta la trafila perché arrivi il portantino, lo si ricoveri in infermeria o ospedale, quello è bello che già morto…”.
Domanda: “Preliminarmente, dunque, occorre superare la concezione vendicativa della giustizia…”.
Barra: “E’ umano, comprensibile, il sentimento di rivalsa che può nutrire chi è vittima di un torto o ne è vittima un congiunto. Ma la giustizia, la sua amministrazione, non può prescindere da quei valori su cui si basa la nostra civiltà giuridica. Che una persona debba scontare la pena a cui è stata condannata è una cosa, che il carcere in quanto tale debba fare schifo, e chi in quel carcere vive e lavora… C’è chi dice: ma il carcere non è mica un albergo a cinque stelle. Nessuno dice che debba essere una beauty farm, ma neppure un posto squallido. Pensiamo ai servizi igienici: perché ci devono essere ancora i cessi alla turca, e la promiscuità della maggior parte delle nostre carceri… Non c’è nessun vantaggio per la collettività a trattare le persone come delle bestie. Questa è violenza, e la violenza genera altra violenza…”.
Domanda: “Simuliamo che il ministro della Giustizia le chieda di essere suo consulente e le chieda di operare per superare la situazione esistente…”.
Barra: “Non ho dubbi, la prima cosa da fare è decongestionare le carceri. Non si capisce perché si vigila e si interviene per altre strutture statali e pubbliche perché siano osservate e rispettate le regole minime, e la stessa cosa non accada per le carceri. La prima cosa da fare è esigere che siano rispettate le regole che ci si è dati. Se si stabilisce che ci sono 50mila posti disponibili nelle carceri, non si possono stipare 70mila persone. La pena consiste nella assenza di libertà, nel fatto che una persona non è libera dei suoi movimenti. Vivere in luoghi sudici, degradanti, senza avere l’assistenza di cui si ha bisogno, è una pena accessoria…
Quindi rendere vivibili le carceri, i luoghi di detenzione, migliorerebbe senz’altro la situazione. Dopodiché dobbiamo evitare di mandare in galera chi è malato. Già queste due misure contribuirebbero ad allentare tensioni e frustrazioni e probabilmente molti suicidi si potrebbero evitare…”.
Domanda: “Alla base di un suicidio ci possono essere una quantità di motivi, Ma diciamo che una persona libera alla fine esercita una sua volontà. La stessa cosa di può dire quando la persona è privata della sua libertà? Per quel che riguarda un detenuto si può, almeno in linea teorica, immaginare una qualche forma di responsabilità da parte dello Stato?”.
Barra: “Per quel che riguarda la salute, la sanità mentale, l’ambiente in cui ci si viene a trovare è elemento fondamentale, c’è una imprescindibile relazione tra l’attività del cervello di un umano e l’ambiente che lo circonda”.
Domanda: “Ma per tornare alla questione della responsabilità?”.
Barra: “E’ evidente che non mi sento di generalizzare. Ogni caso ha una sua storia e merita d’essere indagato con scrupolo. In linea teorica però, sì: nel caso di un detenuto una qualche forma di responsabilità diciamo così ‘esterna’ è ipotizzabile…”.
conversazione con Gianpaolo Catanzariti
Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere presso Unione delle Camere Penali Italiane. Laureato in Giurisprudenza all’università di Messina, iscritto all’ordine degli avvocati dal 1996, patrocinante presso le Magistrature Superiori dal 2008. Docente a contratto in corsi di formazione in materia giuridica ed ambientale. È stato docente a contratto in corsi di formazione in materia giuridica ed ambientale per Istituti Scolastici Superiori. È stato docente in corsi annuali di formazione in materia di “Deontologia e Tecnica del Penalista” per gli avvocati ed i tirocinanti, organizzati dalla Camera Penale di Reggio Calabria. Dal 2013 al 2014 è commissario straordinario del Consorzio A.P.E. “Agenzia per l’Energia” della Provincia di Reggio Calabria. È componente del direttivo della Camera Penale di Reggio Calabria “G. Sardiello”.
——————————————–
Domanda: “Si può cominciare con una piccola lezione di diritto costituzionale, che non fa mai male. L’articolo 32 della Costituzione dice che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritti dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Poi, aggiunge che nessuno può essere sottoposto a cure obbligatorie senza il suo consenso, ma a noi qui interessa la prima parte dell’articolo”.
Catanzariti: “E’ sancito in modo inequivocabile che la salute, sia fisica che psichica, è un diritto fondamentale del cittadino”.
Domanda: “Questo diritto non viene meno, se il cittadino, per qualche ragione, viene privato della sua libertà”.
Catanzariti: “Intuisco dove si vuole arrivare. Il cittadino privato della sua libertà non solo non perde questo diritto costituzionale. Chi lo priva della sua libertà, in questo caso lo Stato se lo rinchiude in una cella o lo fermano le forze dell’ordine, si fa automaticamente garante della sua sanità, e nel caso ne deve rispondere”.
Domanda: “E’ una forzatura sostenere che di un detenuto suicida, proprio per la condizione in cui si trova, privazione della libertà, lo Stato è automaticamente responsabile?”.
Catanzariti: “Bisogna dimostrare che vi sia una responsabilità e quale, da parte delle istituzioni e di chi le incarna… Non può esistere una responsabilità astratta. Occorre provare quanto meno una colpa, se non un dolo: una omissione di sorveglianza, di soccorso…”.
Domanda: “Per provarlo si deve aprire un’indagine”.
Catanzariti: “Questo sì: per ogni suicidio in carcere si dovrebbe aprire un’indagine che consenta di stabilire come sono andate le cose e individuare le eventuali responsabilità…”.
Domanda: “Accade?”.
Catanzariti: “A volte”.
Domanda: “Sul terreno pratico. Un detenuto decide di farla finita e riesce ne suo intento. Che accade?”.
Catanzariti: “Si cerca di stabilire quali siano le cause esatte del suo decesso. Se si immagina che le cause della morte non siano evidentemente riconducibili a una volontà suicidiaria, si dispone diciamo un’autopsia. Interviene il magistrato, nel caso si apre un fascicolo…”.
Domanda: “Ma nel nostro caso si conferma che si tratta di suicidio. Il detenuto ha voluto togliersi la vita e c’è riuscito. Anche in questo caso non si ravvisa comunque una qualche forma di responsabilità da parte dell’istituzione?”.
Catanzariti: “Occorre perlomeno dimostrare che c’è stata un’omissione di soccorso, una istigazione; che il detenuto aveva già manifestato propositi suicidiari e non s’è fatto nulla…”.
Domanda: “Dunque il fatto che sia detenuto, e che lo si sia privato della sua libertà e posto in una condizione comunque anomala, la carcerazione, non è sufficiente…”.
Catanzariti: “Ipotizziamo la situazione classica: la cella vuota dove a un certo punto rientrano i compagni della cella o l’agente della polizia penitenziaria e trova questo detenuto appeso a un chiodo, impiccato. In questo caso il magistrato apre un fascicolo e lo chiude? No, non lo apre. Probabilmente attenderà di avere la relazione di chi ha trovato il corpo, analizzerà se ci sono dei segni che possono fare pensare a qualcosa di diverso, qualsiasi cosa, se ci sono delle stranezze… Diciamo indagini sommarie e poi deciderà se è il caso di approfondire o meno…”.
Domanda: “C’è insomma la possibilità di prendere atto di quanto è accaduto e chiuderla così…”.
Catanzariti: “Per rispondere al vostro quesito esiste certamente una responsabilità diciamo di carattere morale. Ma perché sia giuridica occorre provare almeno una negligenza”.
Domanda: “Per stabilire se vi sia negligenza o omissione occorre almeno chiedersi se vi sia stata…”.
Catanzariti: “Questo appartiene alla coscienza e allo scrupolo di chi indaga…”.
Domanda: “Il detenuto per il solo fatto di essere tale è in una situazione fuori dall’ordinarietà. Se chi lo pone in questa condizione non riesce a garantire la sua integrità fisica o psichica, non dovrebbe essere condannato a una qualche forma di risarcimento?”.
Catanzariti: “Anche in questo caso: occorre stabilire un nesso di causalità tra una colpa, una condotta omissiva o dolosa, e l’evento che si è consumato; una responsabilità dello Stato, e allora pensare a un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato. Anche qui, attenzione. Per esempio, nel caso di una ingiusta carcerazione, non si parla di risarcimento, ma di indennizzo. Il risarcimento è legato a degli elementi di danneggiamento, la condotta di un soggetto che è responsabile per colpo o per dolo strettamente legato all’evento…”.
Domanda: “La questione comunque è questa: nel 2024 almeno un’ottantina di detenuti suicidi. Quelli ufficiali, ma probabilmente è un numero approssimativo per difetto. Almeno sette agenti della polizia penitenziaria. Poi non sappiamo esattamente quanti siano i suicidi sventati. Nei primi tre mesi del 2025 siamo arrivati a una ventina. Su una popolazione carceraria di circa 65mila detenuti. Una media città di provincia ha gli stessi abitanti. Poniamo che a Caltanissetta, in un anno avessero luogo ottanta suicidi ufficiali e altri quattro-cinquecento quelli sventati, si correrebbe subito là per cercare di capire che accade. Le tragedie che si consumano in carcere invece sembrano interessare pochi, quasi nessuno…”.
Catanzariti: “Il carcere, le sue problematiche, le possibili soluzioni, il suo superamento non procura consenso, voti, potere. Il carcere è una discarica sociale; alimentare una politica securitaria è popolare…”.
Domanda: “La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini”, scrive Leonardo Sciascia…”.
Catanzariti: “Attualissima, lucidissima, sintetica descrizione di quello che accade tutti i giorni. Per tornare al carcere, mi sembra evidente che una delle cause che sono alla base di questo numero abnorme di suicidi sia costituito dal sovraffollamento. È lì che occorre operare: con provvedimenti, inutile girarci intorno, che si chiamano amnistia o indulto. Poi si potrà pensare al resto: a rendere le carceri più umane, a immaginare altri modi per scontare una pena a cui si viene condannati; assicurare che durante il periodo di detenzione il carcerato possa davvero imparare un mestiere ed esercitarlo in modo che sia reinserito nella società una volta uscito… A questo proposito: quando si forniscono le cifre dei detenuti che lavorano: non si dice che la maggior parte è impiegata all’interno dello stesso circuito carcerario. Quello non è un lavoro, è un’occupazione: una volta fuori dal carcere il detenuto si trova impreparato a tutto. Alla radice di un suicidio ci può essere sì la disperazione per una lunga pena da scontare, il disagio del luogo in cui ci si trova; ma anche la mancanza di prospettive, il sapere che non si sa come vivere una volta usciti, l’aver paura del futuro…”.
Domanda: “Il sovraffollamento, dicevamo…”.
Catanzariti: “Sovraffollamento e promiscuità. Non sono io a dirlo, lo documentano le statistiche. Quando si rispetta la capienza degli istituti di pena diminuiscono drasticamente suicidi e tentati suicidi…Chi governa lo sa, o dovrebbe saperlo”.
Domanda: “Anche le forze di opposizione”.
Catanzariti: “Ci fosse, un’opposizione…E comunque non dimentichiamo che l’opposizione è anche lei stata al Governo; e non meno dell’attuale maggioranza ha utilizzato in carcere e le questioni legate alla sicurezza in modo strumentale e demagogico”.
Domanda: “Esiste comunque un piano nazionale sulla prevenzione dei rischi suicidario in ambito penitenziario, risale al 2017, dunque un qualcosa su cui far riferimento comunque c’è…”.
Catanzariti: “C’è quel piano, magari da aggiornare o completare. Come avvocati da tempo abbiamo comunicato la nostra disponibilità per dare contributi in questo senso. Perché noi avvocati possiamo essere spesso delle sentinelle che si rendono conto e avvertono nel detenuto di un disagio che può avere tante origini e scaturire infine con un proposito suicidario o comunque estremo. Ora io mi rendo perfettamente conto del fatto che molti che operano nelle strutture ministeriali, specialmente quelli del mondo legislativo e che sono chiamati a elaborare leggi e norme, non hanno conosciuto il carcere, non lo conoscono. Ne avete parlato voi prima: ci sono anche molti agenti della polizia penitenziaria, che si sono tolti la vita. Una polizia, lo dicono gli stessi sindacati degli agenti, che viene abbandonata a sé stessa, anche da quelle forze politiche che un giorno si e l’altro pure parlano tutelarla. La verità è che se ne fregano: per loro la polizia Penitenziaria deve solo svolgere un’attività di controllo della sicurezza”.
Domanda: “Un primo punto di partenza dovrebbe essere quello della conoscenza del fenomeno…”.
Catanzariti: “Non c’è dubbio. Proprio in questi giorni sfogliavo l’ultimo rapporto del Garante dei diritti dei detenuti alcuni dati. Noi nei primi mesi di quest’anno abbiamo già oltre mille casi di aggressioni. È il segno che la violenza nelle carceri è diffusa. Oltre le aggressioni, tra detenuti e tra detenuti e polizia, ci sono oltre 2.400 casi di autolesionismo e oltre 400 casi di tentato suicidio… Non parliamo poi delle manifestazioni di protesta individuale e collettive…”.
Domanda: “E’ eccessivo parlare di uno stato di emergenza permanente nelle carceri?”.
Catanzariti: “Assolutamente sì. Non solo un clima di “ordinaria’ emergenza. Si deve dire chiaramente si troviamo di fronte al sostanziale fallimento dell’intero sistema carcerario. Cosa si fa quando un’impresa fallisce? Si portano i libri in tribunale e si dichiara lo stato di insolvenza, la bancarotta. La cosa vale anche per il sistema penitenziario”.
Domanda: “Un’eventuale commissione parlamentare d’inchiesta potrebbe, a conclusione dei suoi lavori, potrebbe facilmente arrivare a questa conclusione”.
Catanzariti: “Diciamo che è un’estremizzazione molto fondata e giustificata. Una commissione parlamentare d’inchiesta che indaghi sul fenomeno dei suicidi in carcere, alla fine, sicuramente, inevitabilmente, dovrebbe prendere coscienza della condizione disastrata delle carceri e decretarne il fallimento. E ufficialmente certificarlo al Parlamento e alle istituzioni.”.